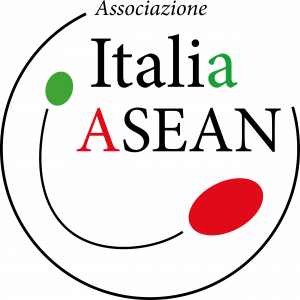Ritratto di una donna contestata in un Paese lacerato dal conflitto
Metà del mondo la odia, metà la ama. Non è facile tratteggiarne il ritratto senza rimanere invischiati in una consistente zona d’ombra, che rende il suo profilo sfocato e misterioso.
Aung San Suu Kyi, Consigliere di Stato della Birmania, Ministro degli Affari Esteri e Ministro dell’Ufficio del Presidente. Premio Nobel per la pace, premio Rafto per la difesa dei diritti umani, premio Sakharov per la libertà di pensiero, Medaglia d’Oro del Congresso degli Stati Uniti. Ma anche moglie, madre, figlia. Posta sotto arresti domiciliari, a fasi alterne dal 1988 al 2010, mentre il marito in Inghilterra moriva di cancro. Sfuggita per un pelo ad una sparatoria organizzata esplicitamente per colpire lei e i suoi sostenitori. Poi condannata dalla critica internazionale per legittimare, o quantomeno negare, il genocidio perpetrato ai danni della minoranza musulmana dei Rohingya in Myanmar.
Myanmar che è tornato sulla bocca di tutti pochi giorni fa, con la notizia del colpo di stato delle forze militari, il Tatmadaw. Tutti i principali leader del partito di maggioranza NLD (National League for Democracy) guidato da Aung San Suu Kyi sono stati arrestati, è stato dichiarato lo stato d’emergenza, e linee telefoniche e trasmissioni televisive sono state interrotte. Per il momento, le accuse sono quelle di aver violato le leggi riguardanti l’import-export, di possedere in casa propria illegalmente quattro radio walkie-talkie. La notizia ha fatto scalpore, ma non ha sorpreso coloro che seguono già da tempo gli sviluppi nel Paese. Difatti, il coup d’etat si inserisce in un contesto dove le frizioni tra la leader politica e le forze militari esistono ormai da numerosi decenni. Così come lo stretto controllo della giunta sulla vita politica, sociale, e religiosa del Paese.
La giunta militare birmana è strettamente legata alla politica del Myanmar dal 1962, quattordici anni dopo l’indipendenza dalla Gran Bretagna e un breve periodo di transizione democratica. Dapprima con il supporto al Partito Socialista, poi con l’annullamento della sua stessa vittoria elettorale, la scusa del broglio è divenuta una costante che ha permesso alla giunta di mantenere il controllo e di reprimere tutti i movimenti pro-democratici che si sono succeduti negli anni. Il più famoso di questi, sfociato nella “Rivolta 8888” (un’insurrezione nazionale il cui fine era la democrazia), iniziata l’8 agosto 1988 e finita appena un mese dopo, è passato tristemente alla storia per essersi concluso in un bagno di sangue. Migliaia di monaci e civili (principalmente studenti) furono uccisi dal Tatmadaw. A causa delle rivolte, venne fondato il Consiglio di Stato per la Restaurazione della Legge e dell’Ordine. Fu in questo contesto che Aung San Suu Kyi emerse come icona nazionale. Aveva vissuto all’estero per gran parte della propria vita, ma proprio quell’anno era tornata nel Paese, per accudire la madre malata.
Figlia del generale e politico birmano Aung San, la vita di Suu Kyi è stata segnata dai risvolti politici del suo Paese fin dalla tenera età. Il padre fu eroe dell’indipendenza birmana dalla Gran Bretagna e primo Ministro della Difesa del governo. Tuttavia, all’apice del suo successo, venne assassinato lasciando una pesante eredità alla figlia, di appena due anni, agli altri due figli, e alla moglie, che pochi anni dopo sarebbe divenuta Ambasciatrice del Myanmar in India. Suu Kyi frequentò le migliori università occidentali ed entrò nelle Nazioni Unite, a New York, dove visse fino alla Rivolta del 1988. Dopo la tragedia, aveva deciso che sarebbe rimasta in Myanmar e avrebbe fondato la NDL. Appena un anno dopo, era agli arresti domiciliari.
Gli anni che seguono il 1988 si alternano tra libertà vigilata e nuovi arresti, la vittoria del suo partito alle elezioni (schiacciante ma annullata, ancora una volta, da un colpo di stato della giunta militare), il premio Nobel della pace, e l’appello della comunità internazionale per il suo rilascio, da Kofi Annan a Papa Giovanni Paolo II. Sopravvive ad una sparatoria, il marito muore di cancro in Inghilterra a migliaia di chilometri di distanza, i suoi figli crescono lontani da lei.
Nel 2010 viene finalmente liberata, e nel 2015 si hanno le prime elezioni libere dal colpo di Stato del 1962. Secondo la costituzione redatta dai militari nel 2008, Aung San Suu Kyi non può essere eletta presidente: i cittadini con familiari stranieri (nel suo caso, due figli britannici) non possono accedere alla massima carica dello stato. Si potrebbe presumere che l’articolo sia stato inserito apposta per impedirle di accedere alla carica, ma di certo non l’ha fermata: per lei è stato creato un nuovo ruolo ad hoc, “Consigliere di stato”, de facto un Primo Ministro.
Dopo qualche anno, l’euforia della comunità internazionale per le sue conquiste si spegne improvvisamente, e viene sostituito dallo sdegno. La paladina dei diritti umani e della democrazia prima nega le violenze perpetrate dalla giunta militare nei confronti della minoranza etnica dei Rohingya nello stato del Rakhine. Poi nel 2019 parla di “quadro fuorviante e incompleto” davanti al Tribunale internazionale dell’Aja per difendere il suo Paese dall’accusa di genocidio. Sebbene la crisi abbia demolito la sua immagine pubblica all’estero, la difesa del suo Stato gli ha valso grande seguito tra la popolazione del Myanmar, assieme al consenso sempre maggiore per come ha saputo gestire la crisi del Covid-19 nel Paese.
Il giudizio sulla sua figura è diviso in due profonde spaccature. Da un lato, chi punta il dito verso il suo silenzio, e impone che le vengano ritirati onorificenze e premi. Dall’altro, chi conosce bene la delicata situazione in cui versa Suu Kyi, e sa che non è facile contrastare la giunta militare e l’immensa influenza politica del Sangha, l’ordine monastico buddhista che di fatto legittima il potere politico di chi governa il Paese. Chi ha l’approvazione del Sangha, militare o politico che sia, ha l’approvazione del popolo. La sua fazione più radicale e nazionalista è nota per gli atti violenti e per diffondere discorsi di incitamento all’odio verso i Rohingya, e potrebbe avere un peso non indifferente nell’influenzare le azioni e le scelte di Suu Kyi per tenere assieme il Paese.
Influenza o meno, nel discorso alla nazione per il nuovo anno Suu Kyi aveva promesso un nuovo approccio verso le negoziazioni di pace, volte a risolvere la fitta rete di conflitti civili nel Paese. Aveva posto le basi per un piano, il “New Peace Architecture”, per raccogliere maggiore partecipazione da diverse forze politiche, organizzazioni della società civile, e i cittadini. Il nuovo colpo di Stato getta un’ombra oscura su questi progetti, e non è dato sapere se essi riusciranno ad avere mai seguito.