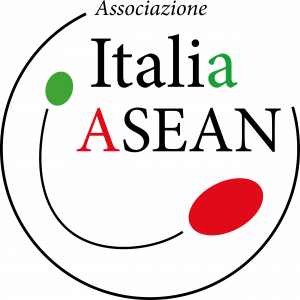Pubblichiamo qui uno stralcio dell’editoriale di Chan Chian Wen, apparso su Nikkei Asia
Una critica comune ai BRICS è che manca della coesione necessaria per la stabilità a lungo termine. Tuttavia, i cinque decenni di esperienza dell’ASEAN potrebbero dimostrare il contrario. Questo gruppo di 10 economie del Sud-Est asiatico funge da caso di studio in tempo reale su come la diversità politica ed economica può coesistere promuovendo al tempo stesso la pace e la prosperità. L’ASEAN comprende Paesi a maggioranza musulmana, buddista e a maggioranza cristiana, tutti con società multietniche e multiculturali. Queste nazioni non condividono nemmeno gli stessi sistemi politici. Tuttavia, la continua esistenza e prosperità dell’ASEAN costituiscono una potente confutazione all’idea secondo cui un mix diversificato di Paesi non può funzionare efficacemente insieme. La comprovata esperienza di neutralità dell’ASEAN sostiene da tempo la stabilità regionale; ora dovrebbe estendere la sua influenza per contribuire a ridurre i rischi di conflitto oltre i suoi confini. Sebbene i BRICS mirino a promuovere il multipolarismo economico, sono spesso visti da Washington come allineati con i suoi rivali geopolitici, Mosca e Pechino. L’ASEAN, senza tale bagaglio, è in una posizione unica per alleviare le preoccupazioni che i BRICS vengano percepiti come anti-occidentali. L’ASEAN può anche trarre vantaggio dalle crescenti borse merci dei BRICS, che offrono l’opportunità di stimolare la crescita economica sostenibile e migliorare la sicurezza alimentare. Proteggendo le economie dipendenti dalle materie prime da un’eccessiva speculazione, gli scambi BRICS aiutano a mitigare la volatilità dei prezzi, una minaccia fondamentale per la stabilità dell’ASEAN. Inoltre, i Paesi BRICS svolgono un ruolo significativo nelle catene di approvvigionamento globali sia per le materie prime che per le materie prime a valore aggiunto. Molti esperti ritengono che il mondo sia sull’orlo di un nuovo superciclo delle materie prime, guidato da decenni di investimenti insufficienti nell’estrazione delle risorse e nelle infrastrutture di raffinazione. I BRICS, con il loro significativo vantaggio in questo ambito, sono ben posizionati per attutire le ricadute socioeconomiche di un tale ciclo – un vantaggio che manca all’ASEAN. Con le tendenze globali che si spostano verso i veicoli elettrici, le batterie al litio, l’energia nucleare, i semiconduttori e l’elettrificazione, l’ASEAN rischia di rimanere indietro senza un impegno più profondo con i BRICS. Inoltre, i BRICS offrono l’accesso a piattaforme alternative per le transazioni finanziarie, come la blockchain. Collegando le valute di regolamento ad attività di riserva neutrali come l’oro, l’ASEAN potrebbe ridurre la propria esposizione ai rischi di forti fluttuazioni del dollaro USA. Affinché l’ASEAN possa mantenere una vera neutralità, deve adottare un approccio indipendente dalla piattaforma per le transazioni finanziarie nel commercio e negli investimenti globali. In conclusione, non è nell’interesse dell’ASEAN osservare passivamente i tentativi di invertire la tendenza verso il multipolarismo, inclusa la creazione di legami più stretti tra BRICS e ASEAN.