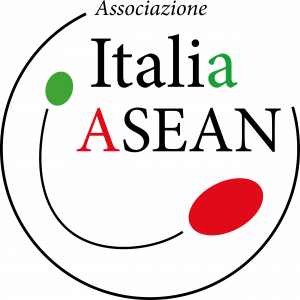Una delle maggiori rotte commerciali al mondo e ricchissima di risorse marine e minerali, quest’area ricopre un’importanza geostrategica ed economica incredibile
Di Walter Minutella
In un mondo in cui l’economia rappresenta il motore trainante del sistema globale, ogni attore cerca di ottenere un’influenza sempre più significativa. I pilastri su cui questo sistema economico si regge possono essere individuati in due elementi chiave: il commercio e le risorse. Nel contesto di questa dinamica, il Mar Cinese Meridionale emerge come una regione che detiene entrambi questi fattori.
Il Mar Cinese Meridionale è un tratto di mare di enorme importanza strategica che confina con numerosi Paesi. Tra quelli che si affacciano su questo mare troviamo diversi membri dell’ASEAN, come Filippine, Malesia, Vietnam, Indonesia, Singapore, Thailandia e Brunei. I restanti attori presenti nell’area sono Cina e Taiwan. Essendo il Mar Cinese Meridionale una delle maggiori rotte commerciali al mondo ed essendo ricca di risorse marine e minerali, tra cui il petrolio, quest’area ricopre un’importanza geostrategica ed economica incredibile, ma non è priva di tensioni.
L’ASEAN in questo contesto è stata fondamentale nella promozione della stabilità e della cooperazione nella regione asiatica fin dalla sua istituzione. Tutto ciò è dovuto anche grazie alla sua filosofia, nota come “l’ASEAN Way”, la quale ha contribuito a creare un ambiente in cui le nazioni membri collaborano per affrontare sfide comuni.
L’ASEAN Way è un approccio diplomatico adottato dall’ASEAN che si basa su principi come il consenso decisionale unanime, la non-interferenza negli affari interni, la sensibilità culturale, il gradualismo e la flessibilità. Questo modello mira a promuovere la cooperazione pacifica tra gli stati membri, evitando il conflitto aperto e incoraggiando la coesistenza armoniosa. Tuttavia, è stato oggetto di critiche per la sua tendenza a ritardare decisioni assertive in situazioni complesse, come quelle che possono verificarsi nell’area del Mar Cinese Meridionale.
Nel contesto delle dispute nel Mar Cinese Meridionale, l’ASEAN si è trovata a gestire tensioni complesse. Da un punto di vista storico, la situazione in quest’area è stata sempre complicata. Fino al 1984, gli Stati membri originali dell’ASEAN avevano una posizione anti-comunista comune, che si rifletteva nella diffidenza verso l’espansionismo cinese. Con l’ammissione di Vietnam, Laos, Myanmar e Cambogia, il dinamismo politico ed economico della regione è cambiato. Questi nuovi membri, con profonde dipendenze economiche dalla Cina, hanno influenzato il modo in cui l’ASEAN affronta le tensioni, indebolendo gradualmente la diffidenza iniziale.
Nonostante il successo dell’ASEAN nel mantenere la pace in una regione storicamente turbolenta, la sua risposta alle dispute nel Mar Cinese Meridionale è stata meno assertiva. Dato il principio di unanimità presente nell’ASEAN Way, era difficile trovare soluzioni che andassero incontro a tutte le necessità. Gli sviluppi recenti, però, mostrano come le azioni degli stati dell’ASEAN sia come singoli che come membri, siano volte a stabilire una sempre maggiore pace e stabilità nell’area.
Nel 2016, la sentenza della Corte Permanente d’Arbitrato dell’Aia rappresentò un momento cruciale nella risoluzione delle dispute territoriali nel Mar Cinese Meridionale, in particolare tra la Cina e le Filippine. La Corte ha respinto le rivendicazioni territoriali cinesi basate sulla “Linea a Nove Tratti”, una mappa disegnata unilateralmente della Cina che stabilisce la sua sovranità su gran parte del Mar Cinese Meridionale.
La decisione della Corte riconobbe il diritto delle Filippine di perseguire risorse nelle loro acque esclusive, respingendo le affermazioni cinesi che limitavano l’accesso e l’uso delle risorse naturali nella regione. Questo verdetto rappresentò una svolta significativa, sottolineando la validità delle rivendicazioni marittime basate sul diritto internazionale, in contrasto con le posizioni unilaterali della Cina.
Negli ultimi anni, a causa di queste dispute, il Vietnam ha iniziato a manifestare crescenti preoccupazioni riguardo alle azioni di Pechino nel Mar Cinese Meridionale. Nello specifico, le inquietudini riguardano diversi episodi: la costruzione di infrastrutture militari sulle Paracelso, manovre volte a impedire a navi di ricerca petrolifere vietnamite di operare in alcune zone; limitazioni delle attività di pesca.
Nel 2020, nonostante la pandemia di COVID-19, il 53° AMM dichiarò il proseguimento degli sforzi per attuare il Codice di Condotta (COC) nel Mar Cinese Meridionale. La persistenza nell’impegno, nonostante le difficoltà, riflette il desiderio dell’ASEAN di stabilire un quadro normativo e diplomatico volto a gestire le tensioni nella regione, per favorire la pace e la stabilità. Tuttavia, persiste una mancanza di posizione comune chiara all’interno dell’ASEAN, evidenziando i contrasti interni tra gli stati membri e il complesso meccanismo che si cela dietro queste dichiarazioni.
Tuttavia, le recenti dichiarazioni dei ministri degli esteri dell’ASEAN pubblicate a fine dicembre 2023, hanno acquisito un’importanza significativa, essendo il primo comunicato autonomo emesso dall’ASEAN sulla questione del Mar Cinese Meridionale. In queste dichiarazioni viene ribadito l’impegno per la pace nel Mar Cinese Meridionale, esprimendo preoccupazione per gli sviluppi recenti. Sottolineano la necessità di risolvere le dispute pacificamente, implementare pienamente la Dichiarazione sul Comportamento delle Parti (DOC) e lavorare rapidamente verso un COC conforme al diritto internazionale, incluso l’UNCLOS del 1982. L’obiettivo dei ministri è quello di promuovere il dialogo come strumento per la stabilità regionale.
Nonostante la risposta un po’ tardiva, le dichiarazioni esprimono forti preoccupazioni per le tensioni recenti, come quelle avvenute tra la Cina e le Filippine, specialmente intorno al banco sommerso di Second Thomas Shoal. Nello specifico, la Cina ha intrapreso azioni percepite dalle Filippine come aggressive, per impedire alle forze filippine di rifornire una nave ancorata, mentre la Cina sostiene la legittimità delle sue azioni in base alla “linea dei nove tratti”. Secondo la Cina tali azioni rappresentano misure di sicurezza necessarie per proteggere i propri interessi nazionali nella regione.
La risposta coalizzata da parte dei ministri degli esteri dell’ASEAN dà un forte segnale di coesione e solidarietà nell’affrontare le dispute interne e internazionali. Tuttavia, alcuni osservatori sostengono che non basta un comunicato e che bisogna fare di più per affrontare le delicate sfide che costellano la zona del Mar Cinese Meridionale in maniera efficace.
Effettivamente, pochi mesi dopo, l’ASEAN ha proseguito nel suo impegno per cercare una maggiore stabilità nella regione. Durante la prima settimana di marzo del 2024 per il summit speciale tra i membri dell’ASEAN e l’Australia a Melbourne, il governo australiano ha elogiato gli sforzi dei membri dell’ASEAN nel delimitare i loro confini marittimi e ha deciso di stanziare un finanziamento di più di 40 milioni di dollari per la sicurezza marittima del Mar Cinese Meridionale. Il finanziamento è stato annunciato durante il cinquantesimo anniversario della partnership dialogica tra le due parti.
La dichiarazione congiunta ASEAN-Australia è un altro passo verso la collaborazione regionale. Tuttavia, resta da vedere se questo impegno finanziario contribuirà in modo significativo alla risoluzione delle tensioni e l’ASEAN potrebbe essere chiamata a svolgere un ruolo più attivo nel promuovere la stabilità nella regione.
Resta da vedere come l’ASEAN si evolverà nel gestire le complesse dinamiche del Mar Cinese Meridionale. Vale la pena menzionare le iniziative minilaterali adottate da alcuni Stati membri, come evidenziato dalle recenti dinamiche tra Filippine e Vietnam. Le due nazioni hanno recentemente firmato un accordo di cooperazione tra le rispettive Guardie costiere. Questo memorandum d’intesa è mirato a ridurre il rischio delle operazioni nelle acque contestate e rappresenta un passo significativo verso la gestione congiunta delle tensioni. Questa iniziativa dimostra come i Paesi membri, anche in modo bilaterale, stiano cercando attivamente soluzioni pragmatiche per promuovere la pace e la stabilità nella regione.