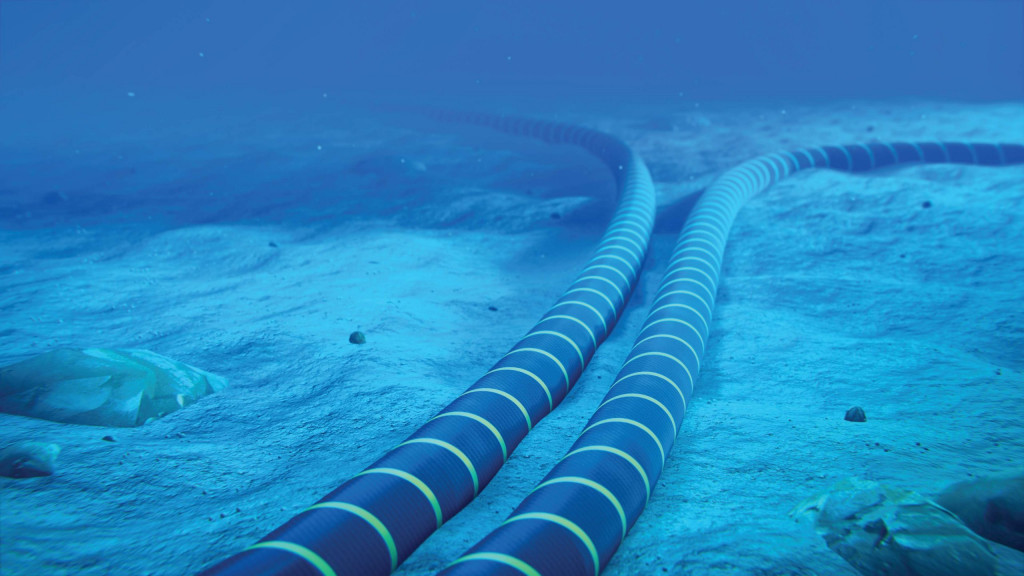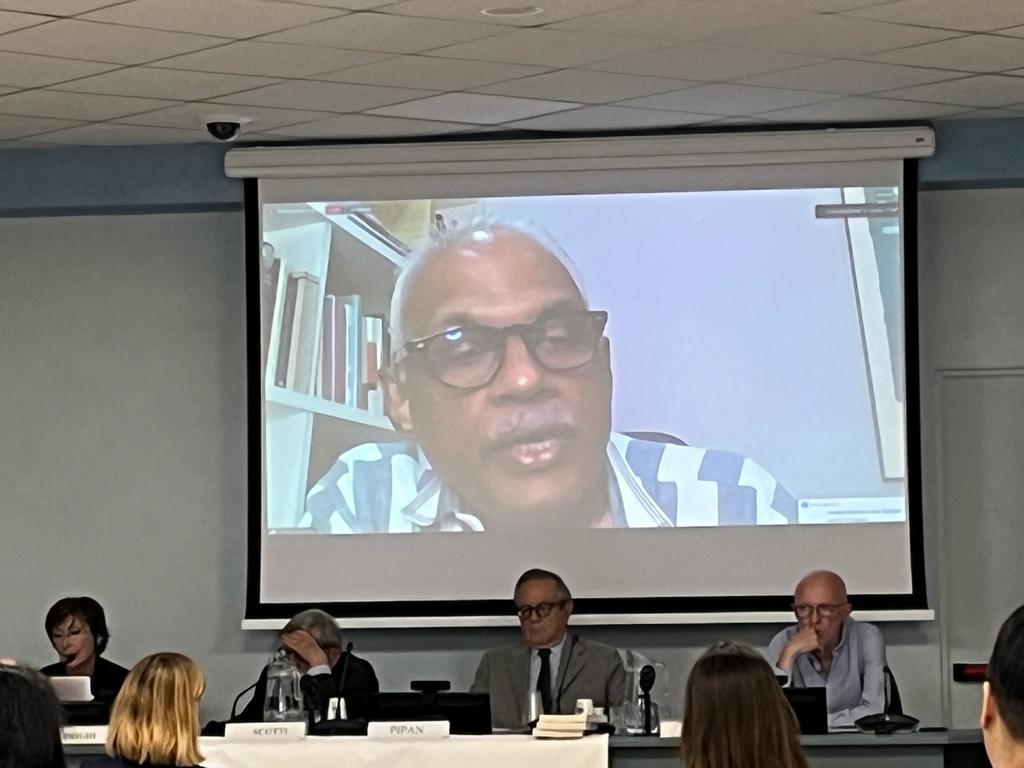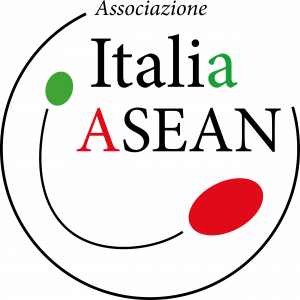Malesia, Indonesia, Thailandia, Singapore e Filippine hanno collegato le loro piattaforme nazionali per i pagamenti via QR code. I consumatori potranno pagare istantaneamente anche con una valuta straniera, con costi ridotti per loro e i venditori. La regione si conferma un polo fintech d’eccellenza mondiale.
Lo scorso giugno, Malesia e Indonesia hanno connesso le proprie piattaforme di pagamento digitale basate sulla tecnologia QR-code. Kuala Lumpur aveva già completato la connessione con Singapore ad aprile e, ancor prima, con la Thailandia. Queste iniziative non sono isolate o bilaterali, ma fanno parte di un progetto coordinato a livello ASEAN e che coinvolge anche le Filippine. Cinque economie di primo piano della regione hanno deciso di coordinare gli standard tecnici delle rispettive piattaforme nazionali così da creare una rete che permetta di pagare con il proprio provider nazionale i codici QR emessi in un altro Paese, rendendo anche istantanea la conversione delle valute. Il progetto era stato annunciato lo scorso anno in occasione del summit G20 dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali presieduto dall’Indonesia. I cinque partner intendono proseguire nel progetto e, in futuro, i consumatori potrebbero anche fare bonifici istantanei o comprare le valute digitali nazionali grazie alla connessione tra piattaforme. E altri Paesi potrebbero connettersi.
L’iniziativa ASEAN si inserisce in un contesto globale di rapido sviluppo dei codici QR, sempre più utilizzati per i pagamenti digitali. Questo metodo di pagamento potrebbe spostare, entro il 2025, 3 trilioni di dollari a livello mondiale. Il suo principale punto di forza è l’accessibilità, dato che, in certe regioni del mondo, è molto più facile avere uno smartphone che una carta di credito. Tale condizione potrebbe spingere il Sud Est asiatico a “guidare una rivoluzione dei pagamenti digitali”. Più del 50% dei consumatori ASEAN che vivono nelle aree urbane utilizza già e-wallet per i propri pagamenti e il numero dovrebbe raggiungere l’84% per il 2025. I numeri non sono altrettanto impressionanti nelle zone rurali, dove nel 2020 meno del 20% dei consumatori usa e-wallet, ma il numero dovrebbe arrivare a sfiorare il 60% nel 2025. Questa tendenza è in linea con quanto sta succedendo anche in Cina con Alipay e WeChat. Il principale freno a questa conversione è lo scetticismo degli esercenti che ritengono le transazioni ancora poco affidabili e troppo costose e che quindi non accettano i metodi elettronici. L’adozione dei QR-code e la loro connessione a livello ASEAN però fornisce una risposta a tali preoccupazioni e contribuirà senz’altro a diffondere i portafogli digitali. I sostenitori dei codici QR affermano poi che il metodo è anche più sicuro, dato che si forniscono meno dati personali ai venditori.
Tale “rivoluzione” avrà un impatto sul futuro sviluppo di molti settori dell’economia, creando vincitori e vinti. Le banche tradizionali, già poco presenti in certe aree dei Paesi ASEAN, rischiano di essere sostituite dai concorrenti fintech. Per pagare con la carta di credito o ritirare contanti da uno sportello, servono un conto corrente e una rete fisica di distribuzione. Due ostacoli non facili da superare per le banche tradizionali, per i costi e la difficoltà nel reperire informazioni sull’affidabilità creditizia dei potenziali clienti. Le società fintech invece non sono “appesantite” da queste esigenze e possono più agilmente attrarre i nuovi clienti del Sud Est asiatico – ed estrarre valore dai dati delle loro transazioni. Si tratta di un mercato dalle immense potenzialità e “sbloccarlo” permetterà alle aziende dell’ASEAN di crescere ancora di più e alla regione di consolidare la sua posizione come laboratorio mondiale per il digitale e il fintech.
Queste iniziative però hanno anche una dimensione politica. I codici QR riducono i costi delle singole transazioni e, come detto, sono facilmente accessibili anche per le persone normalmente escluse dai circuiti bancari tradizionali. La cosiddetta “inclusività finanziaria”, ossia rendere il sistema finanziario accessibile anche al ceto medio e a chi vive nelle aree rurali, è un obiettivo strategico per i governi ASEAN e potrà rendere le loro economie più prospere e competitive. Inoltre, il fatto poi che il coordinamento degli standard tecnici sia avvenuto a livello ASEAN e non meramente bilaterale è prova delle potenzialità dell’organizzazione come foro per discutere e rafforzare l’integrazione regionale, sia economica sia digitale. Si tratta comunque di un progetto ristretto ad alcune tra le economie più competitive e affini tra loro dell’organizzazione. Quali altre piattaforme nazionali potrebbero aggiungersi nel futuro? Il Vietnam ha già lavorato con la Thailandia per connettere i loro sistemi di pagamento QR e, se parteciperà alla rete con gli altri quattro Paesi, tutte le economie più ricche della regione ne farebbero parte. Più difficile è il coinvolgimento dei Paesi più piccoli e con meno risorse.
L’impatto politico di questa iniziativa però va ben oltre l’ASEAN. Il coordinamento delle piattaforme QR permette ai consumatori di pagare il conto in una valuta straniera istantaneamente e con tassi di cambio minimi. Il sistema, in concreto, procede a convertire le valute ASEAN direttamente, senza passare per l’intermediazione del dollaro. La digitalizzazione dei flussi di denaro, quindi, è un ulteriore sfida alla centralità della moneta americana negli scambi internazionali. Infine, il rafforzamento dell’ASEAN come polo digitale innovativo e dinamico accresce il ruolo della regione nella definizione degli standard tecnologici del futuro. Forse, persino capace di ritagliarsi uno spazio in mezzo al duopolio USA-Cina. Coordinare e rendere più facili i pagamenti elettronici crea nuove opportunità. È curioso osservare che, invece, in Italia e in altri Paesi europei talvolta è ancora difficile pagare con la carta di credito e proteggere il ruolo del contante è un tema politico. Un approccio completamente opposto al dinamismo dimostrato dalle aziende e i governi asiatici e che rallenta la corsa delle nostre economie verso la nuova “rivoluzione” digitale.