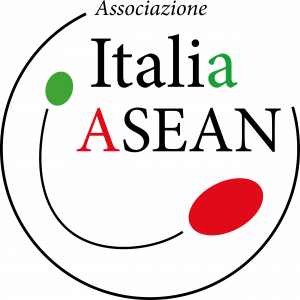Non solo Cina. Diversi Paesi asiatici puntano forte sul continente africano tra investimenti e cooperazione commerciale e diplomatica. Una panoramica
L’interesse cinese per la regione africana è aumentato esponenzialmente nell’ultimo ventennio ma affonda le sue radici nel lontano 1955.
Per poter capire al meglio le vicende attuali, è necessario fare un breve viaggio nel passato. Gli studiosi sono soliti scandire la relazione sino-africana in diverse fasi. Il primo approccio risale ai primi anni ’50, periodo in cui la RPC ha finanziato vari progetti di costruzione edilizia e supportato vari percorsi indipendentisti. Gli anni ’80 hanno dato il via ad una seconda fase della relazione, perlopiù negativa, in quanto si assiste ad un deterioramento del rapporto causato dalla chiusura verso l’interno da parte cinese. Ci troviamo nel periodo in cui il governo cinese inizia a prendere le distanze dalla linea maoista (improntata alla collettivizzazione delle risorse) per passare ad approcci capitalistici (promossi come temporanei e necessari a raggiungere l’ideale regime comunista), che risulteranno determinanti nei successivi rapporti sino-africani. La volontà cinese di supportare il “Terzo mondo” schiacciato dal colonialismo e il modello occidentale, si lega all’intenzionalità di promuovere un modello alternativo.
Gli anni ’90 hanno visto un intensificarsi delle relazioni e un approccio “aggiornato” della controparte asiatica rispetto a quello di mezzo secolo prima: lo spettro d’azione cinese ha incluso settori come il commercio, investimenti, assistenza di vario genere, trasferimento di competenze e formazione, ampliando il suo raggio d’azione e insinuandosi non solo nel settore privato ma anche in quello pubblico.
Il nuovo millennio ha aperto ad un’ultima fase di crescita, continua e rapida. Il 2013 in particolare è stato un anno rappresentativo poiché ha segnato il sorpasso cinese sugli USA per gli investimenti in Africa.
Tutto ciò si può tradurre in cifre: negli ultimi 20 anni il volume totale degli scambi tra Cina e Africa è aumentato del 24.7% e i prestiti dalla Cina hanno raggiunto la cifra di 153 miliardi.
La domanda sorge spontanea: in cosa la RPC ha focalizzato i suoi investimenti?
- Materie prime: l’Africa dispone di quelle materie prime che mancano alla RPC, in particolare quelle del settore manifatturiero. È bene ricordare che la Cina, negli ultimi trent’anni, è passata da essere un’estesa economia agricola al maggior importatore agricolo globale. Questo le è costato il titolo di paese “low-cost” per il costo del lavoro.
- Mercato: il mercato africano è stato visto come particolarmente attraente dagli investitori cinesi sia per la sua estensione che per la recente liberalizzazione, due fattori importanti limitano la forza e il consolidamento dei player stranieri, affievolendo la competizione e facilitando l’inserimento nel mercato.
Il modus operandi degli investimenti cinesi è stato caratterizzato dalla reciprocità, e in questo differisce da quello occidentale. Il Nord del mondo ha rivolto i propri investimenti il cui fine era l’agevolazione dei propri interessi personali, senza guardare al miglioramento delle condizioni locali. L’approccio cinese è stato, invece, onnicomprensivo e win-win: mettendo a disposizione dei partner lo stesso pacchetto di conoscenze che ha condotto la Cina al proprio sviluppo.
La Repubblica Popolare Cinese è l’unico attore asiatico economicamente presente in Africa?
È il Paese del Sol Levante a rispondere a questo quesito. Il capolavoro della diplomazia giapponese in Africa ha un nome: Ticad. Questo acronimo, che significa Tokyo International Conference on African Development, indica una serie di summit organizzati dal governo nipponico e dall’Onu sin dal 1993. Agli eventi, che ad eccezione del 2016 si sono sempre tenuti in Giappone, partecipano più di 40 capi di Stato africani. Ticad ha gettato le basi per progetti “degli africani”, nei quali il Giappone svolge il ruolo di agevolatore attraverso investimenti e know-how: molti degli accordi tecnici e commerciali con Tokyo sono stati firmati proprio durante queste conferenze, le quali sono state, e sono tutt’ora, un ottimo strumento di propaganda per la politica estera nipponica.
I numeri parlano chiaro: tra il 2007 e il 2017 l’investimento diretto estero del Giappone in Africa è passato da 3,9 a 10 miliardi di dollari. Secondo il Direttore degli Affari Africani presso il Ministero degli Esteri giapponese, Shigeru Ushio, l’accesso ai mercati africani è di vitale importanza per le imprese nipponiche e per le start-up africane, le quali potranno svilupparsi approfittando di legislazioni agevoli in termini burocratici.
Il Giappone è partito dalle infrastrutture. Il governo giapponese ha iniziato la sua corsa in Africa sviluppando ambiziosi progetti su scala sovra-regionale: un esempio tra tutti è costituito dal porto di Mombasa, considerato di importanza capitale poiché capolinea dell’autostrada transcontinentale – l’Inter-African Highway 8 – che collegherà Lagos, in Nigeria, alla città keniana. L’intero progetto è nelle mani della Toyo Construction Co., che non è certo la sola compagnia giapponese impegnata nella regione. Secondo l’Overseas Construction Association of Japan, ben 16 aziende di costruttori del Sol Levante sono attive in 22 Paesi africani.
Ma il Giappone non si è limitato al settore delle infrastrutture. I suoi orizzonti sono ben più ampi e hanno raggiunto, in poco tempo, i mercati import-export e le nuove tecnologie, con 796 aziende nipponiche attive in Africa nel 2017. Alcune di queste, come la start-up Nippon Biodiesel Fuel in Mozambico, hanno creato un solido network di fornitori e agricoltori legati direttamente alle proprie attività.
Il settore che ha visto un successo clamoroso del Sol levante è certamente quello energetico e minerario, come dimostra la presenza di uffici delle principali Corporation nipponiche: la Japan Oil, Gas and Metals National Corp., che si occupa dei rilievi per l’individuazione del petrolio in Kenya e dello sviluppo del gas naturale in Mozambico.
“Non c’è due senza tre”: a far compagnia alle potenze cinese e giapponese ci pensa l’India.
Le crescenti necessità commerciali dell’India hanno portato a un suo orientamento verso l’Africa in quanto partner economico sempre più rilevante e a un rinvigorimento della propria presenza navale nell’Oceano indiano occidentale per garantire la sicurezza degli scambi.
Nello specifico, la zona del Corno d’Africa è di cruciale importanza per New Delhi in quanto estremità nord-occidentale della regione dell’Oceano Indiano, di primaria importanza per la propria sicurezza. Storicamente, il porto di Adulis vicino a Massawa era un importante snodo del commercio marittimo tra Europa e Asia su cui si riversavano i mercanti indiani. La stabilità del Corno era già una delle priorità della madrepatria britannica per garantire la sicurezza e la prosperità economica della sua colonia indiana. Ottenuta l’indipendenza nel 1947, l’India adottò un isolazionismo militare che limitò la diffusione della propria influenza regionale. Tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, in concomitanza con il boom economico indiano, la domanda interna di materie prime necessarie a sostenere la crescita è aumentata esponenzialmente. Tutto ciò ha contribuito alla creazione di un ambiente dinamico e alla necessità di diversificare le forniture energetiche. Da quel momento, gli investitori indiani hanno iniziato a guardare alle opportunità offerte dal continente africano.
L’approccio indiano in Africa si basa sul mutuo rispetto e sulla non interferenza nel quadro di una cooperazione sud-sud. Nel Corno, l’India sostiene i paesi più bisognosi con aiuti allo sviluppo mirati e destinati soprattutto al settore agricolo, sanitario e dell’istruzione. Tutti i paesi della regione sono partner del progetto indiano Pan African e-Network, un’iniziativa lanciata nel 2009 dal governo di New Delhi e che punta a condividere con i paesi africani l’expertise indiana nei campi della sanità e dell’istruzione.
L’azione indiana in Africa non si esaurisce all’aiuto umanitario: il governo mira a soddisfare i propri bisogni di sicurezza energetica e alimentare, fondamentali per sostenere la crescita economica e demografica del paese, oltre che a sfruttare le opportunità imprenditoriali e di investimento emergenti. New Delhi è accompagnata dal mondo dell’imprenditoria e dai giganti del settore privato. Tra il 2000 e il 2014 il commercio bilaterale è cresciuto da 10,5 a 78 miliardi di dollari: l’India esporta attrezzature elettriche e altri macchinari, prodotti farmaceutici, alimentari, manifattura.
In sintesi, il ruolo cinese di primo della classe all’interno dello scenario degli investimenti in Africa è costantemente sfidato dalla presenza giapponese e indiana. Il peso dell’India nel continente è in crescita: da un lato aiuta il governo indiano a uscire da una storia di scarso peso nei rapporti internazionali e scarsa attenzione alle relazioni internazionali, e dall’altro soddisfa le necessità di materie prime di un’economia in forte crescita. Il governo giapponese è, invece, consapevole dell’importanza del mantenimento della sua presenza in Africa per tutelare le vie di comunicazioni marittime, in quanto lungo le coste africane passa il petrolio che Tokyo importa dal Medio Oriente. A riprova del fatto che, sebbene vi sia una rivalità, ci sono anche delle convergenze: assicurare la presenza economica nel continente africano è interesse prioritario tanto per la Cina, quanto per il Giappone e l’India.