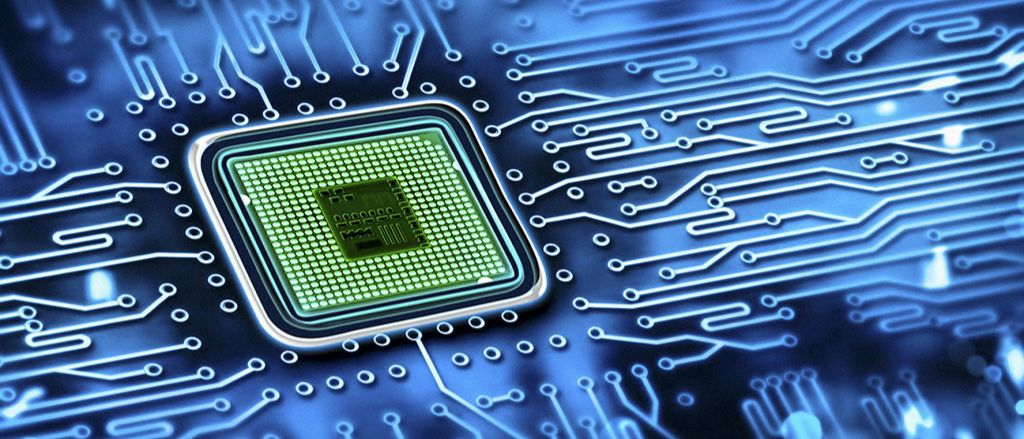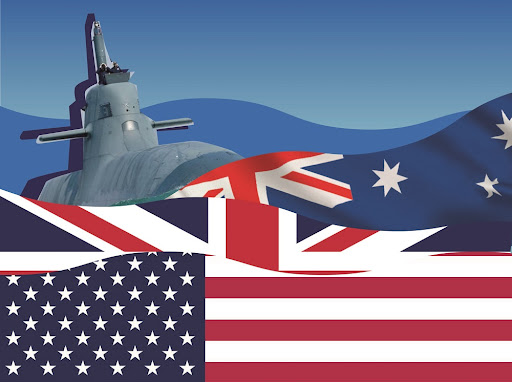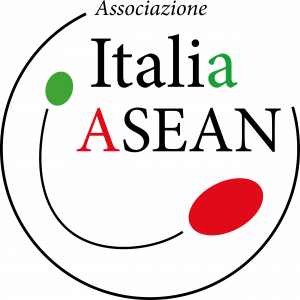La rimozione su richiesta di Manila di due puntate della serie australiana Pine Gap dal catalogo di Netflix Philippines è solo la punta dell’iceberg delle recenti pressioni governative sulle piattaforme digitali occidentali in Asia.
Il 1° novembre il governo filippino ha richiesto e ottenuto la rimozione dal catalogo di Netflix Philippines degli episodi due e tre della serie australiana “Pine Gap”. L’irritazione di Manila è scaturita dall’apparizione di una cartina geografica del Mar Cinese Meridionale rappresentante la cosiddetta “linea dei nove tratti”, tipica delle carte geografiche cinesi di quelle acque ricche di risorse contese tra Cina, Filippine, Brunei, Malesia, Indonesia, Taiwan e Vietnam. L’autorità filippina per la classificazione dei film ha definito gli episodi eliminati come “inadatti alla messa in onda” e il Dipartimento degli Affari Esteri filippino sostiene che l’apparizione di tale mappa va contrastata poiché tesa alla legittimazione della “linea dei nove tratti” col rischio di “corrompere la conoscenza e la memoria dei giovani filippini circa i veri territori del Paese”. La rimozione dei due episodi incriminati è stata pressoché istantanea, avvenendo la stessa serata. La celerità con cui Netflix ha adempiuto alla richiesta del governo filippino non è stata però la stessa nel fornire spiegazioni a Reuters, rispondendo solo a notte inoltrata. La decisione di cancellazione è stata resa pubblica solo il 1° novembre per motivi attualmente sconosciuti.
Non è la prima volta che i servizi di streaming hanno problemi con le autorità circa le rappresentazioni cinematografiche che toccano temi sensibili nella regione. Il Vietnam è l’esempio di come la pressione dei governi locali possa divenire vera e propria coercizione. Se Pine Gap si è vista eliminare due episodi nelle Filippine, in Vietnam la serie è stata interamente cancellata dal catalogo per lo stesso motivo. Similmente, nel 2019 Hanoi aveva ritirato dalle sale il film della Dreamworks “Abominable” oltre alla rom-com cinese “Put Your Head on My Shoulder” e il dramma politico americano “Madam Secretary” dai servizi on demand per evitare di “ferire i sentimenti dell’intero popolo vietnamita”.
Netflix è solo uno degli attori in questa relazione tra governi e piattaforme. Nell’Asia-Pacifico si trova il 40% degli utenti dei social di Meta, ex Facebook, che ha quindi grandi interessi nell’area. Solo il Vietnam conta 100 milioni di utenti e un mercato dal valore di un miliardo di dollari. I filippini sono i più attivi sulle piattaforme Meta, passando in media oltre quattro ore al giorno online secondo eMarketer, mentre gli indonesiani usano WhatsApp come principale mezzo di comunicazione e informazione. Dato il grande impatto di Meta sulle popolazioni della regione, i governi locali pongono particolare attenzione a quanto avviene sulle sue piattaforme, in particolare dal 2017.
Facebook collabora con il Ministero dell’Informazione e Comunicazione (MoIC), la Banca di Stato del Vietnam, il Dipartimento Generale della Tassazione e il Ministero della Pubblica Sicurezza per identificare e perseguire i reati politici sui social media. Sotto minaccia di oscuramento e con l’obbligo di mantenere sede legale, server e dati locali in Vietnam, Facebook avrebbe preso parte alle attività di censura del governo di Hanoi: secondo Transparency Report, dal 2019 la repressione del dissenso nel Paese è aumentata del 983%, anno in cui Facebook ha buttato giù 200 siti antigovernativi. Dai Facebook Papers, documenti trapelati quest’anno insieme a un’inchiesta del Washington Post sulla società californiana, emerge che a inizio 2021 Mark Zuckerberg avrebbe dato il placet alla censura di molti dissidenti vietnamiti sulla piattaforma in concomitanza con il tredicesimo Congresso del Partito comunista vietnamita, fondamentale per la selezione della leadership dei cinque anni successivi. YouTube di Google non è escluso da queste dinamiche. Nel 2019 è stato costretto a rimuovere contenuto critico verso il governo di Hanoi cancellando oltre 7000 video e 19 canali. Dal Play Store sono stati eliminati 58 giochi vietnamiti, come anche da Apple.
Facebook di Meta ha un certo peso anche nelle Filippine. Dal 2017, partecipa col governo di Rodrigo Duterte allo sviluppo delle infrastrutture internet veloci nel Paese. Il bilanciamento di Facebook nei rapporti col governo è difficile: Duterte non ha accolto bene la chiusura nel 2020 di vari account collegati alla polizia e all’esercito filippino a causa del loro ruolo nella guerra alla droga avviata dal Presidente. Duterte ha minacciato il social dicendo che per i filippini ci sarebbe stata una vita dopo Facebook e che i delegati del social avrebbero dovuto dare spiegazioni dell’accaduto.
In Indonesia, il governo sfrutta la Legge sull’Informazione Elettronica e le Transazioni (ITE) per contrastare i dissidenti. Invocata circa duecento volte dal 2019, secondo Amnesty International questo eccessivo ricorrervi viola la libertà d’espressione. A completare questa legge, entrerà in vigore da dicembre 2021 il Regolamento Ministeriale 5 che permetterà di tassare le piattaforme straniere e coinvolgerle nel processo legislativo, pena l’oscuramento per evitare che venga diffuso materiale “proibito, illecito o che disturbi l’ordine pubblico”. Per questo motivo Facebook collabora con il Ministero della Comunicazione e della Tecnologia dell’Informazione (Kominfo).
Sotto la superficie del mare digitale, la libertà di espressione si congela sempre di più, ingrandendo così l’iceberg della repressione.