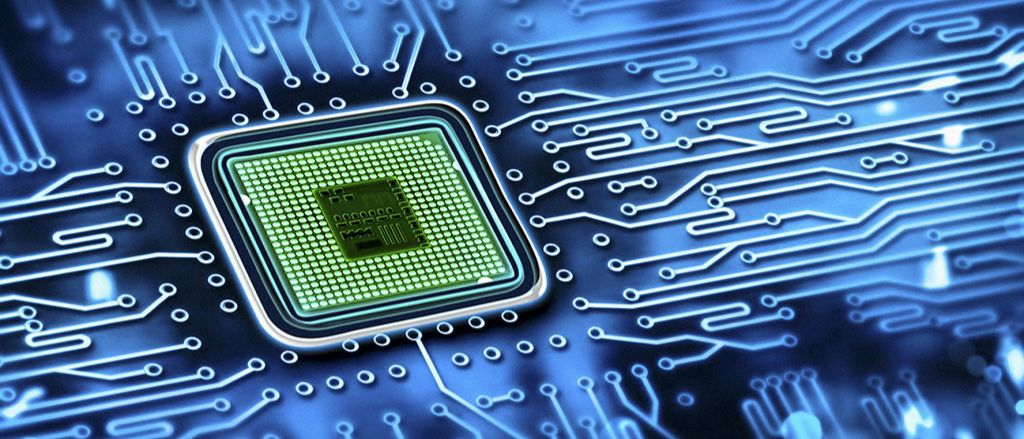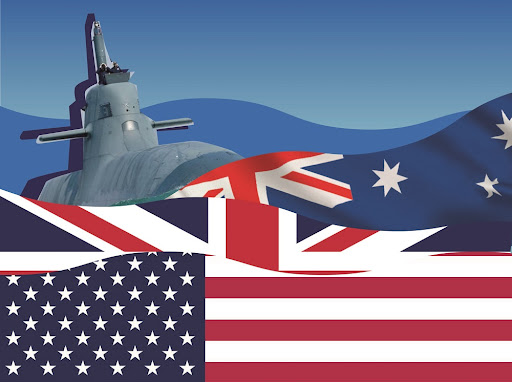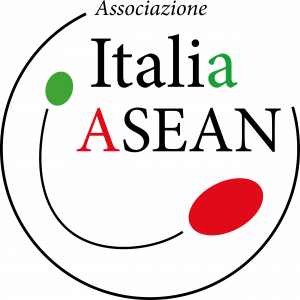Dall’e-riel cambogiano alle ultime dichiarazioni del MUI indonesiano: i Paesi del Sud-Est si interrogano su come regolamentare il mercato delle criptovalute e pensano a monete digitali ufficiali.
Articolo a cura di Fabrizia Candido
Si chiama ‘Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill’ il progetto di legge a cui l’India il 23 novembre ha annunciato di star lavorando. L’obiettivo sembrerebbe essere quello di vietare le criptovalute private (sebbene si faccia riferimento ad alcune, vaghe, eccezioni) e, allo stesso tempo, aprire la strada a una valuta digitale ufficiale emessa dalla Reserve Bank of India. Non è una notizia del tutto inaspettata, se si considera che nel corso del 2021 il governo indiano aveva persino preso in considerazione la possibilità di criminalizzare il possesso, l’emissione, l’estrazione, il commercio e il trasferimento di asset in criptovalute. Il timore, come espresso dal Premier Narendra Modi qualche settimana fa, è che le criptovalute possano “finire nelle mani sbagliate, rovinando la gioventù”. Ma l’India non è l’unico Paese asiatico in cui le criptovalute, private e/o di Stato, sono oggetto di discussione.
A interrogarsi su come regolamentare il mercato, per definizione deregolamentato e intrinsecamente volatile, delle criptovalute e a immaginare una valuta digitale ufficiale ci sono anche alcuni dei Paesi ASEAN.
In Indonesia, la banca centrale del paese dal 1 gennaio 2018 vieta l’uso di criptovalute, incluso il Bitcoin, come mezzo di pagamento: la rupiah è l’unica valuta legale nel Paese. Tuttavia, è permesso il trading di criptovalute come opzione d’investimento insieme ai commodity futures, ovvero contratti futuri in cui ci si obbliga a scambiare una prefissata quantità di merce a una data prefissata, e a un determinato prezzo fissato alla data della contrattazione. Lo scorso 11 novembre, però, il Consiglio Religioso Nazionale Indonesiano Ulema (MUI) ha dichiarato il trading di criptovalute haram e non conforme alla Sharia, ad eccezione di quei casi in cui esso comporta “chiari benefici”. Sebbene la decisione del MUI non significhi che tutto il trading di criptovalute verrà interrotto in Indonesia, ci si aspetta che il decreto dissuaderà parte dei musulmani dall’investire in criptovalute. Secondo il ministero del commercio indonesiano, alla fine del 2020 il numero di trader aveva raggiunto i 6.5 milioni.
Meno rigida è la Malesia, che tramite uno statement sul sito web della Bank Negara dal 2014 avverte i propri cittadini che il Bitcoin non è riconosciuto come valuta legale nel Paese, che la banca centrale non ne regola le operazioni e che pertanto si raccomanda prudenza nell’utilizzo di questa criptovaluta. Nel luglio 2021, tuttavia, la nota piattaforma di scambio di criptovalute Binance è stata bannata dal Paese.
A non optare per il ban, ma per una rigida e selettiva regolamentazione che gli permetta al contempo di essere ancora un hub attivo, c’è infine Singapore. Circa 170 aziende hanno richiesto una licenza dalla Monetary Authority of Singapore (MAS), portando il numero totale di aziende che cercano di operare ai sensi del suo Payment Services Act a circa 400, dopo l’entrata in vigore della legge nel gennaio 2020. Da allora, solo tre società di criptovalute hanno ricevuto le tanto ambite licenze. “Non abbiamo bisogno che 160 di loro aprano un business qui. La metà di loro può farlo, ma con standard molto elevati, che penso sia un risultato migliore” aveva commentato in un’intervista a Bloomberg Ravi Menon, Direttore del Monetary Authority of Singapore
A guardare invece ad una valuta digitale di Stato sono Cambogia e Laos. La Cambogia, nello specifico, ha intrapreso un ambizioso progetto per far crescere la sua Central Bank Digital Currency (CBDC). Bakong, questo il nome scelto per la valuta digitale cambogiana, grazie ad un massivo progetto pilota oggi conta già 5.9 milioni di utenti. Secondo quanto riportato dal Nikkei Asia, durante la prima metà del 2021, gli utenti Bakong hanno effettuato circa 1.4 milioni di transazioni per un valore di 500 milioni di dollari. Il progetto è stato presentato per la prima volta dalla Banca nazionale della Cambogia (NBC) nell’ottobre dello scorso anno, basato sulla tecnologia blockchain sviluppata congiuntamente dalla società fintech giapponese Soramitsu. Obiettivo principale l’esplorazione dei pagamenti digitali, l’incoraggiamento all’uso della valuta locale e la riduzione della dipendenza dal dollaro, e l’inclusione finanziaria dei cittadini rimasti fuori dal sistema bancario tradizionale.
Lo scorso ottobre la fintech giapponese Soramitsu è stata ingaggiata anche dalla Banca centrale della Repubblica Democratica Popolare del Laos, per esplorare l’emissione di una CBDC laotiana. Una versione digitale del kip supporterebbe le autorità nel raccoglimento dei dati necessari a misurare il polso dell’economia, come la quantità di denaro in circolazione. Ma non solo: l’iniziativa segna un tentativo da parte del Laos di estendere la portata della sua valuta mentre lo e-yuan digitale si profila come una presenza potenzialmente invasiva nella nazione del sud-est asiatico per cui la Cina è il secondo partner economico.
Anche il Vietnam ha deciso di esplorare la creazione di una propria valuta digitale, con la Decisione 942 del Primo Ministro che si allinea con la strategia per digitalizzare il governo entro il 2030. La policy invita la State Bank of Vietnam a ricercare, “sviluppare e sperimentare l’uso della valuta digitale basata sulla tecnologia blockchain.” In Vietnam, l’utilizzo di criptovalute per effettuare acquisti è illegale, ma queste vengono ancora acquistate attivamente come strumenti di investimento: il Paese è tra i primi tre a livello globale per percentuale di persone che affermano di detenere una qualche forma di criptovaluta, secondo un sondaggio di Statista.