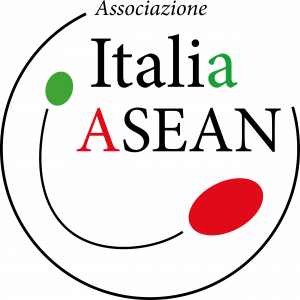L’intenzione per l’integrazione di soluzioni rinnovabili e più sostenibili c’è, ma potrebbe non essere abbastanza: per far fronte alla complessità nella gestione della rete energetica del futuro, l’APAC non potrà fare a meno di sistemi di controllo smart che operino tra fornitura, rete, domanda e stoccaggio, rendendo il processo più efficiente, affidabile e sicuro attraverso l’interconnessione.
Articolo a cura di Fabrizia Candido
Nella regione dell’Asia-Pacifico, anche nota come APAC, risiede il 60% della popolazione mondiale (circa 4,3 miliardi di persone) e viene prodotta circa la metà delle emissioni mondiali di anidride carbonica. La regione, oltre a Cina, India e Giappone (tre dei sei Paesi maggiormente responsabili per le emissioni di CO2) ospita alcune delle economie in più rapida crescita al mondo. Entro il 2040 si prevede infatti che la domanda di energia da combustibili dell’APAC raggiungerà i 43.6 petawatts, con una domanda globale che raggiungerà i 197.8 petawatts. Il bisogno di svincolare la crescita economica dalle emissioni di gas serra è dunque urgente.
Per accelerare il passaggio a un approvvigionamento energetico diffuso, accessibile e a basse emissioni di carbonio, è necessaria una maggiore ottimizzazione di ogni aspetto del sistema energetico, nonché maggiore coordinamento e cooperazione tra ogni componente. Ciò richiede una migliore comprensione e migliori meccanismi per monitorare e controllare le modalità in cui reti elettriche, edifici, impianti industriali, reti di trasporto e altri settori ad alta intensità energetica si integrano e interagiscono tra loro.
Il futuro sistema energetico ospiterà più energia da generatori intermittenti (i pannelli solari producono energia solo quando splende il sole e le turbine eoliche solo quando soffia il vento), e sarà più decentralizzato: ci saranno molti più asset fisici collegati alla rete di produzione e a quella di distribuzione, dove i flussi di energia diventeranno sempre più dinamici e multidirezionali. La complessità del sistema di alimentazione aumenterà in modo significativo. Ciò potrebbe mettere a rischio la stabilità e le prestazioni della rete, portando a problemi come squilibri di frequenza, blackout, brownout e sovraccarico di capacità. Senza dati in tempo reale, analisi avanzate e automazione, i più complessi sistemi energetici del futuro diventeranno praticamente impossibili da gestire.
È qui che entra in gioco la digitalizzazione, con raccolta e analisi di dati, intelligenza artificiale e apprendimento automatico. L’aggiunta di enormi quantità di fonti variabili di energia ha creato la necessità di sistemi di controllo smart che operino tra fornitura, rete, domanda e stoccaggio, rendendo il tutto più efficiente, affidabile e sostenibile attraverso l’interconnessione.
Più nello specifico, la crescente ricchezza di informazioni generata sui consumi energetici e sui modelli di produzione può essere utilizzata per pianificare al meglio la trasformazione del settore, sia a livello macro che micro: il monitoraggio e l’analisi dei dati consentono una migliore capacità predittiva della produzione di energia rinnovabile, consentendo l’ottimizzazione dell’intera filiera. Utilizzando i dati raccolti da varie fonti, come dati sul consumo di elettricità, dati sul prezzo dell’elettricità e dati meteorologici, l’intelligenza artificiale può inoltre essere impiegata per riconoscere modelli e/o fornire previsioni probabilistiche circa capacità produttiva, domanda o penuria di energia.
In breve, la digitalizzazione offre l’opportunità di sfruttare la disponibilità di dati per ottimizzare la transizione energetica.
Nel 2020, l’Australia ha lanciato il suo Distributed Energy Resource Register, un registro che fornisce un database di informazioni sui dispositivi DER (Distributed Energy Resources) installati nel mercato nazionale dell’energia elettrica. Il registro raccoglie informazioni fondamentali per il programma DER dell’operatore del mercato energetico australiano (AEMO). L’interconnessione tra i dispositivi DER e il registro consente ad AEMO di gestire al meglio la rete elettrica e garantire energia affidabile, sicura e conveniente per tutti i clienti.
Un altro esempio di digitalizzazione al servizio dell’ottimizzazione energica proviene dall’India: il governo indiano ha sviluppato l’India Energy Dashboards (IED), un portale open source che raccoglie dati e rapporti mensili sull’uso di elettricità, petrolio e gas naturale del Paese. Il governo indiano ha anche creato la Building Energy Efficiency Program Dashboard, con l’obiettivo di incoraggiare l’utilizzo di dispositivi ad alta efficienza energetica nelle strutture residenziali sensibilizzando i consumatori. Il database online mostra in tempo reale il numero di luci installate per regione, insieme ai rispettivi risparmi annuali sui costi, riduzioni annuali di CO2 e picchi di domanda evitati.
Ancora, dal 2013 anche il governo cinese ha prioritizzato i sistemi di monitoraggio energetico online. Gli edifici del settore pubblico a tutti i livelli di governo hanno implementato tali sistemi per ottenere dati in tempo reale, consentendo l’automazione della gestione dell’energia e un metodo trasparente per valutare l’efficienza energetica delle strutture. La maggior parte dei sistemi di monitoraggio energetico online per il settore pubblico cinese sono attualmente sistemi decentralizzati. Ad esempio, il governo locale di Hangzhou, insieme ad Alibaba Group, ha implementato il progetto City Brain per migliorare l’efficienza energetica dei trasporti. Nell’ambito del progetto, una piattaforma cloud acquisisce immagini dalle telecamere stradali interconnesse, le traduce in dati sul traffico, analizza i risultati e fornisce le soluzioni più efficienti tramite algoritmi, reindirizzate poi a strumenti smart quali i semafori intelligenti. Ciò ha permesso di ridurre la congestione da traffico nella città di Hangzhou del 10%, con conseguenze sul livello di inquinamento e sull’uso di combustibile.
Infine, su scala più ampia, il governo di Singapore ha recentemente completato un modello digitale in scala reale dell’intera città, Virtual Singapore, che include repliche digitali 3D di ogni edificio della città. Per gli urbanisti focalizzati sull’efficienza energetica, la città gemella digitale offre la capacità di simulare con precisione come i nuovi sviluppi e i cambiamenti di pianificazione nella città potrebbero influenzare una serie di indicatori relativi all’energia, tra cui l’irraggiamento solare, i flussi di traffico stradale e pedonale, il riscaldamento e il raffreddamento e altri fattori. Dati i limiti dimensionali della città, il modello digitale fornisce un sistema estremamente utile per testare gli interventi di pianificazione nel mondo reale.
In conclusione, la regione APAC ha compreso che nella rotta verso il mastodontico obiettivo della transizione energetica, non si potrà fare a meno delle molteplici e diversificate soluzioni smart che la digitalizzazione e la disponibilità di dati rendono possibili.