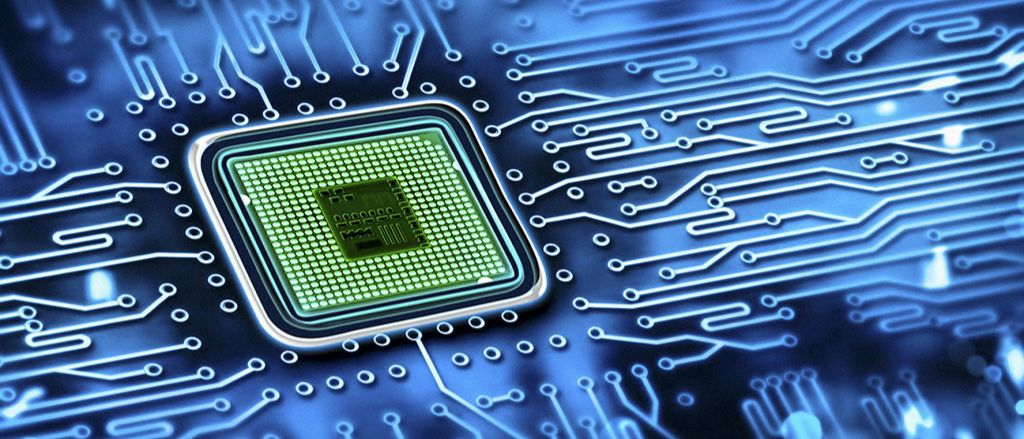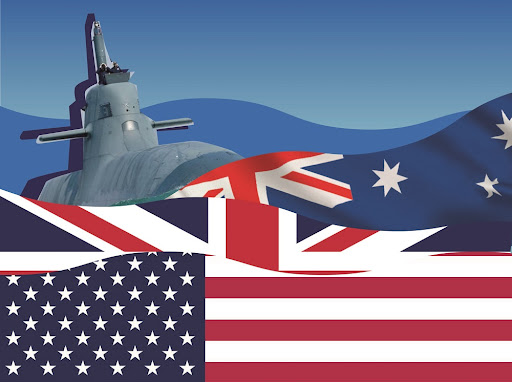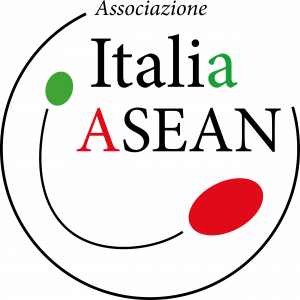Speciale G20 Indonesia
Giacarta ha il potenziale di dirigere l’attenzione del mondo verso l’Asia in via di sviluppo, ma potrebbe perdere l’occasione di uscire dal mainstream del dialogo multilaterale. Ecco le sfide della sua presidenza di turno
Dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022 l’Indonesia guiderà la presidenza del G20. È la prima volta che Giacarta ottiene la posizione di guida del gruppo multilaterale, che comprende 19 tra le maggiori economie e l’Unione Europea. Nata nel 1999 come piattaforma per la discussione di tematiche economiche, si è presto estesa ad altre questioni. Il passaggio di consegne tra Italia e Indonesia, completato in occasione del summit a Roma del 30-31 ottobre è stato l’occasione per metterle in luce: crisi climatica, emergenza sanitaria, gestione dei mercati globali sono solo alcuni dei termini più menzionati dai leader riuniti in quell’evento.
La presidenza dell’Indonesia, che sfocerà nel summit di Bali dell’ottobre 2022, apre una stagione che vedrà protagoniste le economie emergenti, non solo nei contenuti del dialogo tra i Paesi del G20: nel 2023 sarà il turno dell’India, seguita dal Brasile e poi dal Sudafrica. “Questo è un onore per noi, per l’Indonesia, e allo stesso tempo una grande responsabilità, che dobbiamo svolgere bene”, ha detto il Presidente indonesiano Joko Widodo, meglio conosciuto come Jokowi. Non per niente il tema del 2022 è “Recover Together, Recover Stronger”, espressione che contiene quel carattere di inclusività in cui la presidenza a guida indonesiana cercherà di puntare.
Secondo quanto dichiarato in chiusura del summit di Roma, nel 2022 andrebbero concretizzati i progetti in ottica di sicurezza sanitaria, di riduzione delle emissioni e di gestione dei mercati per contenere la crisi economica provocata dalla pandemia. Sfide non semplici, che Giacarta dovrà portare sulle proprie spalle in quanto unico membro ASEAN incluso nel club.
Crisi climatica e sviluppo sostenibile
Come altri paesi del Sud-Est asiatico, l’Indonesia è esposta a eventi climatici estremi sempre più frequenti (2510 segnalazioni nel 2020, contro le 535 del 2005). Jokowi ha affermato che l’Indonesia, durante la sua presidenza, spera di offrire una piattaforma per partenariati globali e finanziamenti internazionali per sostenere la transizione energetica verso fonti rinnovabili più pulite.
Giacarta conosce bene le difficoltà delle economie emergenti davanti alle trasformazioni che la transizione energetica richiede. Quella che viene considerata una delle principali soluzioni sul tavolo è, per i Paesi in via di sviluppo, una sfida che richiede innanzitutto l’accesso universale all’energia elettrica di qualità. La sola Indonesia ha la sovranità su 17,500 isole e una capitale che sta sprofondando, mentre la politica economica è profondamente radicata intorno alle fonti fossili. I progetti sono tanti e ambiziosi, come un parco solare a Java che verrà completato entro la fine del 2022 e sarà, con i suoi 145 Megawatt, il più grande del Paese.
Lo sviluppo sostenibile richiede un approccio diverso rispetto a quello adottato dal Nord globale, e l’approdo dell’Indonesia a capo di una delle organizzazioni rappresentative di questa realtà potrebbe portare nuovi spunti spesso sottovalutati. Dal 2014 Jokowi ha iniziato a introdurre molte riforme in un’ottica di accrescimento del benessere individuale, tanto che il coefficiente di Gini per la disuguaglianza di reddito in Indonesia ha ripreso a scendere dopo quasi 15 anni: oggi si è stabilizzato intorno al 38,2 (quello dell’Italia è a 35,9). Rimarrà importante anche il tema della cooperazione sanitaria per sostenere i paesi in difficoltà, che rimane un argomento importante anche per la politica interna: negli ultimi anni, per esempio, Jokowi ha introdotto una revisione delle assicurazioni sulla salute in un’ottica di universalizzare il sistema sanitario.
Giacarta mantiene delle politiche fiscali prudenti, al punto che il debito nazionale si mantiene sotto il 40% del Pil. Questa visione politica è accompagnata, non senza criticità (come nel caso delle leggi sul lavoro) da un netto appoggio alle liberalizzazioni. In questo modo le riforme di Jokowi hanno contribuito a migliorare la posizione dell’Indonesia nell’indice Doing Business della Banca Mondiale dal 120º posto nel 2014 al 73° nel 2020. In questo senso Giacarta rimane un membro gradito del G20, e potenziale esempio di sviluppo economico per il resto della regione.
Cooperazione internazionale
La cautela dell’Indonesia rimane alta anche in politica estera, dove Jokowi ha saputo tenere legami attivi sia con la Cina che con gli Stati Uniti. Il controllo sul debito pubblico ha permesso di accogliere i progetti cinesi della Belt and Road initiative per accelerare i piani di sviluppo infrastrutturale, mentre rimane alta l’attenzione verso altri potenziali investitori. Non per niente la landing page del sito dedicato alla presidenza dell’Indonesia fa emergere l’intenzione di presentare il Paese al mondo, renderlo più attrattivo e degno di fiducia da parte della comunità internazionale. Da un punto di vista politico, inoltre, Jokowi ha saputo gestire le conflittualità interetniche nel Paese e rappresenta l’unico leader musulmano effettivamente arrivato alla presidenza tramite procedure democratiche regolari.
Cautela e compromessi: la presidenza indonesiana contiene quella leadership accomodante che si presta a tamponare le frizioni ideologiche in una fase storica particolarmente complessa per la comunità internazionale. Diverso, ma complementare a un modello politico ed economico affine alle democrazie occidentali. Il G20 di Roma intendeva riaffermare il modello di relazioni internazionali multilaterali, mentre il mondo rischia di scivolare verso piccole o grandi conflittualità di vicinato che ostacolano la cooperazione e la supervisione di attori esterni. La presidenza indonesiana cercherà di riportare l’attenzione verso quei Paesi che devono colmare il ritardo col resto del mondo.