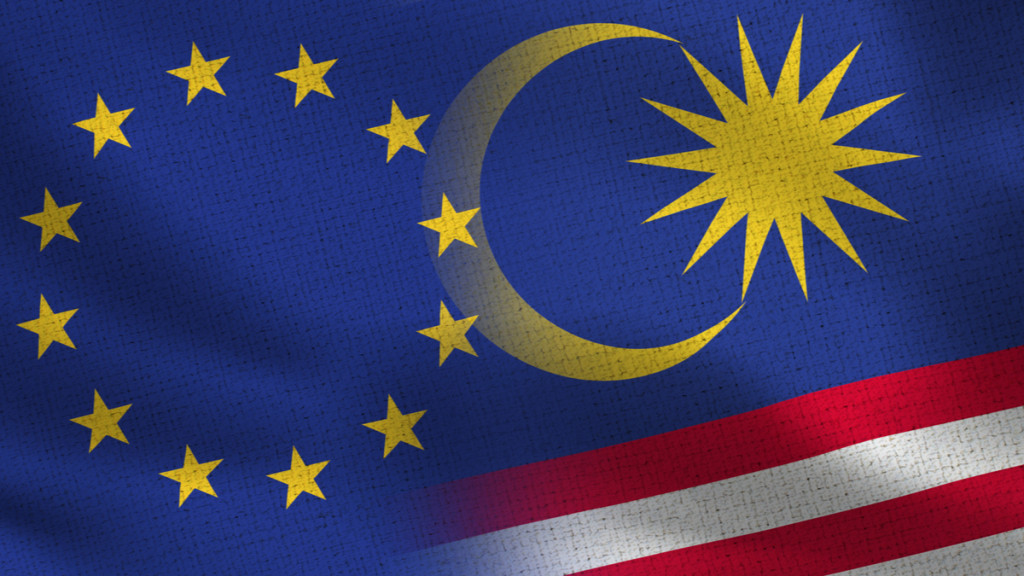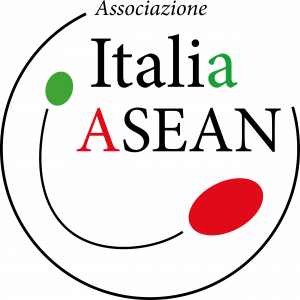Tokyo vuole essere protagonista nelle dinamiche economiche dell’ASEAN post-Covid e grazie alla transizione energetica punta a limitare l’espansione cinese nell’area
Nel recente incontro dei leader del G-7 è stato messo sul tavolo della discussione anche il complicato dossier sui cambiamenti climatici e la transizione energetica. I leader politici si sono ormai resi conto che il tema deve essere affrontato di petto per arrivare ad una soluzione che limiti il più possibile gli effetti negativi del cambiamento climatico. Se i Paesi industrializzati sono in grado di mettere in campo ingenti risorse economiche e know-how per garantire la transizione energetica e raggiungere la de-carbonizzazione delle economie, lo stesso non può dirsi di quelli a medio reddito che stanno attraversando un processo di sviluppo economico, largamente basato su risorse energetiche fossili, ma che mancano sia delle risorse economiche che delle conoscenze tecnologiche per mettere in campo progetti di conversione ecologica delle loro società. Il Sud-Est asiatico si trova in questa condizione e necessità del sostegno dei Paesi sviluppati per poter portare a compimento l’ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2016-2025 in modo da ridurre la dipendenza dalle fonti fossili.
Pertanto, il Giappone si appresta a investire per favorire la transizione energetica dell’ASEAN. In un recente meeting tra i Ministri dell’energia dei Paesi ASEAN e il Ministro dell’Economia e commercio del Giappone è stata rilasciata una dichiarazione comune che impegna le parti a rafforzare la cooperazione e il Paese del sol levante a investire 10 miliardi di dollari in supporto alla transizione tramite la Japan Bank for International Cooperation (JBIC) e altre istituzioni finanziarie. Questo denaro sarà finalizzato a incrementare le rinnovabili, l’efficienza energetica, la transizione dal carbone al gas, l’utilizzo di tecnologie per la cattura e stoccaggio della CO2 e per ultimo il trasferimento di know-how. Tokyo vorrebbe aiutare ognuno dei 10 Paesi ASEAN a stilare una road map per arrivare a zero emissioni, senza però indicare precisamente una deadline entro la quale raggiungere l’obiettivo. Va però ricordato che ad oggi solo tre Paesi ASEAN, cioè Cambogia, Myanmar e Laos, hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali per il raggiungimento della neutralità entro il 2050 e il Giappone sta premendo su tutti gli altri membri affinché stilino dei piani e definiscano le tempistiche.
Gli investimenti in sostenibilità ambientale promossi dal Giappone non devono essere visti come una mossa a sé stante, ma rientrano in una logica di sistema più grande che il Paese asiatico ha da tempo messo in campo. Infatti, negli ultimi anni Tokyo è tornata ad interessarsi al Sud-Est asiatico e ha rafforzato le relazioni diplomatiche ed economiche con i Paesi ASEAN. Nello specifico, il Giappone è molto attivo in investimenti nei comparti della difesa, delle infrastrutture, delle risorse e dell’automotive e ultimamente ha lanciato un piano di sussidi fiscali per favorire lo spostamento delle imprese nipponiche con sede in Cina verso il Sud-Est asiatico. Tokyo ritiene che investire nell’ASEAN, delocalizzandovi imprese e aiutare la regione nella transizione ecologica possa tornare utile sia per se stessa in termini di crescita economica, sia per controbilanciare l’influenza cinese nell’area Per esempio, diminuire la dipendenza dal carbone dei Paesi ASEAN indirettamente significherebbe limitare l’influenza cinese verso di loro visto che Pechino è un grande investitore e costruttore di centrali termiche a carbone.
È chiaro che tutte queste azioni, oltre ad avere un risvolto economico, hanno anche una valenza geopolitica. Tokyo guarda con allarme alla Belt and Road Initiative di Pechino e in conseguenza di ciò è stato l’unico Paese asiatico a non aver aderito alla Asian Infrastructure Investment Bank nata appunto per finanziare la nuova Via della Seta cinese. D’altra parte, il Giappone può contare sulla Asian Development Bank con sede a Manila. L’istituto, fondato negli anni ’60 e di cui Tokyo detiene la percentuale più ampia e pertanto ne esprime sempre il presidente, ha contribuito a investire massicciamente nel Sud-Est asiatico e ora sta orientando i flussi finanziari affinché sostengano la transizione energetica nell’ASEAN.